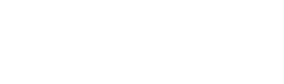Varco la linea bianca ed entro sul terreno di gioco. Applausi, musica. La passeggiata al centro del campo per il rituale saluto al pubblico e il lancio della monetina testaocroce restringe drasticamente lo spazio dei miei pensieri che passo dopo passo si sciolgono nel presente. Occupo gli ultimi posti della fila rosanero, dietro agli arbitri che conducono, il capitano e gli altri miei compagni; qualche metro al mio fianco gli avversari. I tifosi sparsi sulle tribune applaudono, mentre dalla curva i cori di incitamento sintetizzano in un urlo complessivo la passione per i colori della città. Sono oramai andati i tempi in cui gli stadi erano esauriti, calorosi, vivi; ora sugli spalti non rimangono che i resti di una passione sportiva che lentamente regredisce e si sposta su altre discipline. Cammino. E mentre cammino sento di voler correre. Vorrei correre. Sarà l’erba, sarà perché l’area del rettangolo di gioco è una concreta estensione del mio spazio mentale, sarà perché i ricordi di centinaia di partite assimilati nei muscoli impongono una reazione istintiva immediata, ma io voglio correre. E ogni volta mi vedo costretto a questa passeggiata forzata, innaturale, preimpostata e utile solo a fini televisivi. Fosse per me farei almeno un allungo fino a metà campo ma non decido io e ormai lo faccio da anni. Aspetterò ancora una manciata di minuti il tempo dei saluti. Ora sono nella partita non penso a niente mi guardo attorno. Osservo tutto lo stadio a 360 gradi e mentre passeggio lento l’energia trattenuta indirizza i miei pensieri verso l’erba: ascolto i piedi che mi indicano di nuovo le condizioni del terreno di gioco, morbido. Respiro. Sensibilizzo le mie gambe e le mie braccia. Respiro. Non vedo l’ora di correre. Scroscianti applausi, una variegata gamma di colori nella tribuna laterale e distanti micromovimenti animano gli ultimi minuti prima del match. Ed una volta posizionati verso la tribuna centrale in ordine cerco con lo sguardo Deborah con le bimbe. Le vedo. Le saluto con un sorriso e alzo la mano. Loro mi salutano. Deborah che sopporta lo stress del mio lavoro. Chissà cosa pensano del loro papà. Poi l’inno della Serie A composto da Giovanni Allevi: decora la domenica calcistica cercando di far assomigliare la Serie A ad un torneo di tutt’altro valore e dagli introiti ben diversi. Ogni volta va a sbattere contro le mie preferenze musicali alternative ed io lo trovo, purtroppo, del tutto inappropriato alla manifestazione che rappresenta. La telecamera passa davanti a tutti ed io non la guardo. Non ti guardo, non vi guardo; mi limito a guardare dritto dritto la tribuna centrale. L’arbitro fischia. Alzo il braccio destro, sempre il destro e saluto lo stadio. Uno ad uno in bocca al lupo, do il cinque, in bocca al lupo, ai miei avversari, in bocca al lupo, e li guardo, in bocca al lupo, tutti, negli occhi. Ed infine la “terna?” arbitrale. Sono libero. Come un bambino da solo su un prato nel verde delle montagne mi muovo in uno scatto e un salto liberatorio e mi posiziono ai bordi del cerchio di centrocampo e della lunghissima attesa giunta ormai alla sua implosione definitiva.