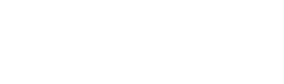Questo articolo è stato pubblicato il 9 aprile 2022 a pagina 19 del numero 22 dell'Essenziale.
di Patrizio Ruviglioni.
Ci incontriamo in un bistrot nel centro di Alessandria. Dalla scorsa estate Alessandro Gazzi, 39 anni, è collaboratore tecnico dell’allenatore della squadra locale di calcio, in serie B. Arriva a piedi e si scusa per il ritardo: viene da una seduta impegnativa, dice, quella della ripresa dal weekend di campionato. Occhi piccoli e barba incolta, sotto il cappotto montgomery indossa un maglione a V da cui spunta una camicia bianca. Il ristorante è al piano terra di uno storico hotel a quattro stelle. I pochi clienti sono tutti in pausa pranzo, il locale è così silenzioso che ci spinge a parlare sottovoce.
“Ho scelto questo posto perché mi sembrava comodo per entrambi, soprattutto per te che vieni dalla stazione”, esordisce prima ancora che glielo chieda. “E poi perché di lunedì è uno dei pochi aperti qui”. La sua tendenza a riportare tutto a una sorta di fondamentale ordinarietà investe ogni ambito della sua vita, compreso il lavoro.
Per molti, Gazzi è un privilegiato come tanti: un ex calciatore professionista, che ha realizzato il sogno di quando era bambino, vivere “di pallone”. Nato a Feltre, vicino a Belluno, negli anni novanta si è formato nei settori giovanili di Montebelluna e Treviso (all’epoca eccellenze locali) e poi nella Lazio miliardaria di Sergio Cragnotti. E ha trascorso gran parte della carriera in serie A, da centrocampista centrale, mediano, con il Bari, il Torino e il Palermo. Buon piede sinistro, propensione a recuperare palloni al servizio dei compagni più estrosi, non è mai stato un campione in senso assoluto, e neanche un campione da nazionale, come ci tiene a ricordare lui stesso. Ma è comunque uno che “ce l’ha fatta”. Quando giocava nel Bari era adorato dai tifosi, che alludendo al colore dei suoi capelli cantavano: “Con il rosso non si passa”.
Nello spogliatoio
Ma nella vita di Gazzi, che non nega le soddisfazioni avute nello sport, c’è molto altro oltre al calcio: scrive libri e racconti, è appassionato di rock (ha scelto il suo procuratore, da ragazzo, perché anche lui ascoltava i Beatles) e di letteratura (cita Don DeLillo e Karl Ove Knausgård, di cui ha amato La morte del padre). Ha studiato al Dams ed è a un esame dalla laurea in scienze motorie, con un tirocinio in corso in uno studio di fisioterapia. Poi, sì, è stato anche calciatore ad alti livelli di serie A.
E quando parla di sé e del suo mestiere, lo fa da normalizzatore, senza retorica. “Non mi sono mai sentito diverso dai miei compagni”, racconta. “Nello spogliatoio siamo tutti diversi l’uno dall’altro. Forse sono stato un po’ più timido della media, specie quando ho avuto a che fare con compagni nuovi. Ma del resto non funziona così, tra colleghi, in ogni luogo di lavoro?”.
E “lavoro” è la parola che torna più spesso mentre siamo a pranzo. È infatti il fulcro della sua recente autobiografia, Un lavoro da mediano (66thand2nd), titolo che richiama la canzone di Luciano Ligabue Una vita da mediano, dedicata a un mediano eccellente come Gabriele Oriali, all’Inter tra gli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta. Ma nella canzone il calcio è “vita”, per Gazzi solo una professione. Si è occupato del libro nei ritagli di tempo, cercando di fare un lavoro diverso dalle biografie degli altri calciatori, piene di aneddotica e spesso dettate dal giornalista di fiducia. “Non le leggo mai”, dice.
“Scrivere mi è venuto naturale come passo successivo alla lettura. Ho cominciato otto anni fa, quando una dottoressa, per farmi rendere al massimo in campo, mi ha suggerito di mettere per iscritto le sensazioni che provavo quando giocavo. Ci ho preso gusto, ho cominciato a scrivere un blog. Racconto il calcio per quello che è per me, cioè un mestiere che viaggia su binari paralleli: quello delle emozioni, del cuore, della testa; e quello del professionismo, delle prestazioni. Quando si ha un rendimento sottotono, spesso è questione di testa, magari ci sono di mezzo vicende personali, che i tifosi in buona fede ignorano”.
Aspettative
Gazzi sa bene quanto sia difficile per un atleta tenere in equilibrio questi due aspetti. La prima volta che ha sofferto per il calcio aveva vent’anni: aveva lasciato la sua città per trasferirsi a Roma e giocare nel settore giovanile della Lazio, ma le cose non erano andate bene e dopo due anni era stato costretto a ripartire dalla serie C, nella Viterbese. “In quel momento”, racconta, “volevo smettere. Ero annichilito, depresso”. La fiducia dell’allenatore, che da subito lo schierò in campo con continuità, fu fondamentale per uscirne, anche se giocava in una categoria inferiore a quella che aveva pensato di meritare. “Spesso è proprio un problema di aspettative tradite. Mi ero illuso di poter avere una carriera subito ai massimi livelli. Abbassare le richieste nei confronti di me stesso mi ha aiutato”.
La seconda crisi risale all’autunno del 2010, quando giocava nel Bari, in serie A. La squadra era reduce da un’annata straordinaria, tifosi e giornalisti prevedevano un campionato in linea con quello precedente, ma al rientro qualcosa si era inceppato: le prestazioni del gruppo erano deludenti e il club si ritrovò ultimo in classifica. Per di più Gazzi, a causa di un infortunio, rimase fermo per un mese. “In quel periodo soffrivo di attacchi d’ansia, mi sentivo annebbiato, paralizzato. In campo pensavo a un movimento, al più elementare, e il corpo non rispondeva. Anche lì è stata questione di aspettative e di pressioni. Abbassare le prime e isolarmi è stata la chiave”.